LA PROMESSA

Era voluto partire da solo. Aveva aspettato che la meteo fosse perfetta e non si era nemmeno inventato una balla, una qualsiasi, per lasciare a casa il suo socio.
«Ma non lo so cosa faccio settimana prossima. Hai studiato quello che ti ho mandato?» Aveva detto cercando di sviare la sua attenzione su altro.
«Va che sei vecchio per le solitarie» gli aveva ghignato quell’altro, con gli occhi piccoli e la schiuma della birra ancora sulle labbra.
«Ho ben ancora da venire vecchio, parla per te.»
Se n’era andato così, senza neanche bere, che spiegazioni mica aveva voglia di darne. Era la sua montagna, e allora? Per quella salita non voleva nessuno e bon, che lo lasciassero stare. Lo zaino lo aveva già preparato e quando arrivò a casa poté coricarsi presto. Per rilassarsi fece mentalmente l’inventario delle cose più importanti: i ramponi, uno spezzone di corda, la pila frontale, la picca, gli occhiali da sole, la borraccia… con uno scatto si sedette sul letto. Il fazzoletto, il fazzoletto di suo fratello. Possibile che stesse per dimenticarlo?
“Allora, sei pronto? Muoviti, è tardi!”. Usciti di casa di nascosto, come i ladri, che ai genitori queste cose si dicevano una volta fatte. Partiti a passo veloce: arrivare sul ghiacciaio il prima possibile, questo dovevano fare. Il cielo bucato di luna piena, gli alberi scuri e severi, fruscio di foglie e passi e respiri. Salgono in fretta. Sotto i piedi gli aghi di larice, nel naso profumo di miele, poi terra compatta, poi pietre, l’aria che si fa frizzante. Arrivano ai piedi del ghiacciaio che è stata quasi una corsa. Suo fratello piega le gambe, preme con le mani sopra i ginocchi, respira forte.
“Colpa tua, che sei voluto venire. Si fa fatica in montagna.” (Read More)
Nina dai capelli d’oro
parte quinta e ultima (parte quarta, parte terza, parte seconda, parte prima))

Estate 1984
Angela parcheggiò l’automobile all’ombra di un albero. Il viaggio era stato lungo e la strada tra buche, sassi e rovi che l’avevano mezza invasa, le aveva richiesto una certa abilità per salire fin su.
«Forza Matilde, siamo arrivate!»
La bimba scese dell’auto. «Dove andiamo adesso?»
«Adesso devi essere brava e camminare un po’. In cambio, ti racconterò una fiaba bellissima»
«Dove andiamo?» chiese di nuovo Matilde tendendo il braccio per prendere la mano della mamma.
«Andiamo a vedere un lago dalle acque verdi verdi, ma prima passiamo dalla casa di nonna»
Angela prese per mano Matilde e insieme si avviarono lungo il breve sentiero che conduceva alla conca dell’alpeggio. Si fecero strada nell’erba alta che pizzicava le gambe e dispensava profumi, mentre nugoli di cavallette si alzavano a ogni loro passo. In lontananza nell’erba macchie gialle e rosa mostravano una fioritura quasi selvaggia. Angela si fermò a guardare le baite. Tutte erano chiuse, le porte e le finestre sprangate da assi invecchiate, messe di sbieco. Quella degli Zampitelli aveva fin il tetto sfondato, e un giovane faggio usciva sfrontato dal centro della casa, spingendo le sue foglie verdi verso l’alto.
«Nel lago, ha preso la fiolina e l’ha buttata nel lago!» Ah, Angela se le ricordava bene le parole della Tilde, altroché se le aveva sentite. Che sua mamma, mica la piangeva mai, e se piangeva, qualcosa di molto brutto era successo. E poi quella mattina, la fuga in Svizzera di tutta la famiglia, mai più saputo niente degli Zampitelli, mica c’era per loro un angelo a dirgli che potevano rientrare.
Intanto il prato cantava di grilli e l’ora già calda incattiviva i tafani. Angela si fermò dritta davanti alla baita dei Tarchera. Appoggiata al ballatoio, contro il legno ormai marcio della ringhiera, stava una piccola bicicletta, mezza divorata dalla ruggine mentre una vecchia sedia di fòrmica di un verde sbiadito aspettava lì, in bilico su sole tre gambe, che una, chissà perché, mancava.
Finalmente, giunse alla sua baita. Il tetto era integro e l’intonaco ben conservato. Accarezzò il muro con le punta delle dita e lo sguardo fu attirato dal grosso campanaccio appeso sopra la porta. Se n’era completamente dimenticata. Con una cordicella legata al batacchio la fece suonare come faceva il Piero tanti anni prima.
«Mica era così silenzioso qui quando ero piccola io,» disse Angela alla bimba «era tutto uno scampanare di mucche e di capre. Era di Amelia sai questo campanaccio. Il nonno ce l’aveva quando era giovane, era la mucca più bella dell’alpeggio, aveva vinto anche un premio, sai.»
«E adesso dov’è?» chiese Matilde
«È in cielo, a pascolare con il nonno! Dai, andiamo!»
Angela si alzò, raccolse un filo d’erba e cominciò a masticarlo. Ne porse uno anche alla bambina. «Senti che buono,» le disse «dai che giochiamo alle caprette mentre saliamo!»
Si alzarono e iniziarono a camminare sotto il sole, accompagnate solo dal frinire dei grilli.
«E perché non ci sono più le mucche?»
«Perché adesso le persone che prima le allevavano sono diventate anziane»
«Come la nonna?»
«Eh sì, come la nonna.»
«E perché non le tieni tu le mucche?»
«Perché, perché… perché devo far pascolare te! Beee Beee» disse Angela ridendo.
«Beee Beee» fece eco la bambina.
Quando entrarono nel bosco, l’aria si fece più fresca. Era bello camminare sul tappeto di aghi dei larici, profumato e morbido sotto le scarpe.
«Mi racconti la fiaba mamma?»
«Certo, adesso te la racconto, ma prima devi sapere una cosa: perché si realizzi la magia della fiaba non possiamo mai smettere di camminare, solo quando avrò quasi finito potremo fare una sosta e riposarci un attimo. Sei pronta?»
«Pronta!» disse Matilde battendo le mani.
«Tanto tempo fa, ancora prima che arrivassero i pastori, in questa valle c’era un castello.»
«Un castello?! E adesso dov’è?» chiese Matilde smettendo per un attimo di camminare.
«No, non ti fermare» le disse l’Angela seria «te lo spiego mentre camminiamo, lascia parlare me. C’era un castello dove viveva una famiglia felice con tanti bellissimi bambini. La più piccola si chiamava Nina e, a differenza di tutti gli altri, aveva i capelli biondi biondi, e quando c’era il sole brillavano come l’oro.»
«E poi cos’è successo?»
«Un attimo Matilde», disse Angela mentre prendeva fiato sul sentiero ripido. «A Nina piaceva uscire sulla torre del castello per far luccicare sui capelli al sole, ma un giorno un corvo tutto nero e cattivo iniziò a girarle attorno. Craaa craaa faceva il corvo»
«Craaa Craaa» le fece il verso Matilde.
«Un giorno il corvo, sempre più invidioso dell’oro dei capelli di Nina, la rapì. La prese con gli artigli e la portò via con sé. Volarono a lungo, sopra boschi, pietraie e nevai, fino a quando arrivarono al lago. Adesso» disse Angela alla bambina «contiamo dieci passi e poi ti racconterò il finale della fiaba.»
«Uno, due, tre…»
Quando Matilde arrivò a dieci, Angela la invitò a sedersi.
«Adesso possiamo riposare un attimo, perché il volo del corvo fu molto, molto lungo. Avrebbe voluto lui quei capelli colore dell’oro, così portò in giro Nina tutto il giorno, fino al tramonto. Nina era quasi felice di volare, pensava che il corvo, volando, fosse diventato suo amico… Ma invece la bestiaccia stava cercando il lago, e quando lo vide si gettò a tutta velocità verso di esso, e non appena vi fu sopra lasciò cadere Nina»
Matilde si mise una mano davanti alla bocca e sgranò gli occhi, quasi fosse lì, a vedere la scena.
«Forza andiamo, manca pochissimo ad arrivare al lago e quando saremo lì ti racconterò la fine.»
Madre e figlia camminarono ancora una ventina di minuti, ormai la conca del lago era in vista e presto entrambe raggiunsero lo specchio d’acqua. Angela vide le acque verdi e piatte attraverso un velo di sudore. Si rivide bambina per mano alla Tilde, guardare fissa dentro l’acqua alla ricerca del pesciolino dalle pinne d’oro. Prese un respiro profondo.
«Ma prima che Nina finisse inghiottita dalle acque, dal lago uscì una fata bellissima con i capelli biondi e lunghi come quelli di Nina. La bambina finì tra le sue braccia e la fata, con i suoi poteri magici, la trasformò in un pesciolino con le pinne d’oro. Il pesciolino è vivo ancora oggi e nelle giornate di sole, le bambine più fortunate riescono a vedere luccicare le sue pinne.»
«Voglio vederlo, voglio vederlo!» Disse Angela.
«Adesso andiamo in riva al lago, così puoi guardare per bene dentro l’acqua, ma sappi che non è facile vederlo, è un pesciolino che sta sempre nascosto. »
Si avvicinarono alla riva. Angela cercò di ricordare dove la Tilde aveva seppellito il panno bianco. Ricordava di aver raccolto due legni e di aver messo insieme una piccola croce, ma ne era passato di tempo! Si sedettero sulla riva. Angela si abbracciò le ginocchia mentre Matilde volle a tutti i costi bagnarsi i piedi.
«Guarda che è fredda!» le disse Angela, ma Matilde era troppo presa dal pesciolino dalle pinne d’oro per preoccuparsi del freddo.
Guardò la bambina mentre si bagnava i piedi e pensò a che cosa ne sarebbe stato di Nina, se le cose non fossero andate com’erano andate. Dov’erano gli Zampitelli? Che cosa facevano i loro figli? L’immagine di una tavola imbandita, il rumore delle scodelle, il profumo della polenta e il gusto del latte si riaffacciarono prepotenti alla sua mente. Com’era contenta la Tilde quando la tavola era affollata, quando doveva gridare come una matta per avere un po’ di silenzio! Ripensò all’ultima estate che aveva passato all’alpeggio, quando giocava da sola perché tutti se n’erano andati e quando anche a loro, a un certo punto, non restò che andarsene. Sorrise alla bambina che era stata, e che trotterellava un po’ felice un po’ no, dietro le vacche del Piero. Ci era tornata poco, in montagna, e fin dei conti andava bene così. Solo, la notte prima aveva sognato il lago, aveva sognato che Tilde tirava fuori Nina dalle acque. Allora aveva pensato che forse era ora di tornare, che Nina l’aveva chiamata per far sì che non si dimenticasse di lei.
Una brezza sottile increspava appena il filo dell’acqua mentre le nubi a tratti oscuravano il sole che poi riappariva gettando lame di luce sulla superficie.
«L’ho visto, l’ho visto!» gridò a un certo punto Matilde. «Mamma, l’ho visto!»
«Vieni qui, fatti dare un bacio, bambina fortunata!» disse Angela tirandosi vicino la figlia e stampandole rumorosamente le labbra in fronte. «Davvero l’hai visto?»
«Sììì!» rispose Matilde sollevando le braccia, «ho visto la pinna tutta luccicante!»
«Bene,» ribatté la madre «allora adesso possiamo fare merenda» e tolse dallo zainetto un panino con il formaggio, avvolto nella stagnola. «Avrai fame!»
«Ma Nina non torna più?» chiese Matilde con la bocca piena «Resta sempre un pesciolino?»
«Sì, Matilde, l’incantesimo non si può sciogliere, nemmeno con le fate.»
Angela lasciò che la bambina finisse il panino. La brezza si era fatta più pungente e il sole calava lento dietro i larici. Il caldo prepotente della salita era già un lontano ricordo. «Tieni qualche briciola» disse «le diamo a Nina e ai suoi amici.»
Insieme si avvicinarono nuovamente alla riva. La bambina gettò le briciole nell’acqua. «Vieni Nina, vieni!»
«Adesso andiamo Matilde, inizia a far fresco, saluta Nina»
«No, dài, aspetta, voglio vedere ancora una volta il pesciolino!»
«Eggià» le disse Angela «guarda che il pesciolino non si fa vedere quasi mai da nessuno, hai avuto molta fortuna sai? Ma non pensare di riuscire a vederlo due volte! Forza, saluta Nina»
«Ciao Nina, ciaooo» si arrese Matilde.
«Ciao Nina» ripeté Angela sottovoce.
Lentamente si allontanarono dal lago. Il sentiero era in ombra e il pomeriggio si era fatto dolce e fresco, come quando il Piero cominciava a richiamare le vacche per portarle in stalla e per i bambini dell’alpe era quasi l’ora dei giochi. Angela sorrise. “Ciao, Nina!” urlò questa volta, in direzione del lago. E prendendo per mano la bambina tornò lentamente verso le baite, che se ne stavano avvolte nell’ombra, come animali addormentati.

Nina dai capelli d’oro
Parte quarta (parte terza, parte seconda, parte prima)

La Tilde si svegliò con un balzo, sì svegliò che era già seduta sul letto e le mancava il respiro.
«Cosa c’è, che è notte?» le domandò il Piero svegliatosi all’improvviso pure lui.
«Niente, vado a vedere dov’è l’Angela»
«È a letto l’Angela, dove vuoi che sia»
Aveva sognato che il Giovanni Zampitelli era tornato, era entrato in casa, e si era portato via l’Angela. L’aveva strascinata per un braccio e l’aveva portata su, verso il lago. La Tilde lo aveva rincorso, ma lui era troppo veloce e presto lo aveva perso di vista. Quando era arrivata al lago il Giovanni non c’era più, ma la Tilde aveva trovato l’Angela. Solo che l’Angela non era più lei, era un pesciolino e brillava dentro il lago con le pinne tutte d’oro.
“Vieni a casa, Angela!”
“Non posso mamma,” aveva risposto la sua voce, proveniente dal fondo del lago “adesso vivo qui.”
A quel punto la Tilde si era svegliata di colpo, talmente inquieta che nel mezzo della notte era andata a controllare se l’Angela dormiva effettivamente nella sua stanza o se era stato più che un sogno. Dormì tribolata per il resto della notte.
La mattina dopo, il Piero intinse lentamente un tozzo di pane nel latte. Lo addentò senza convinzione, bevve un poco e abbandonò la colazione sul tavolo. Si infilò la camicia, e fece per uscire. La Tilde lo vide sulla porta appoggiarsi improvvisamente e con forza allo stipite.
«Tilde!» urlò alla donna. «Vai su te ai pascoli oggi. Sto mica bene»
La Tilde lo guardò in silenzio, prese il bastone e cominciò a radunare le bestie.
«Angela, vieni!» disse alla bambina «Andiamo noi al pascolo oggi»
Ci andava il Piero di solito, e a volte si portava l’Angela, a volte no. La Tilde camminava a passo deciso, ma silenziosa e con la testa bassa. Non gli era mica piaciuto vedere il Piero così. L’Angela era ancora piccola. Speriamo che non è niente di grave, pensò. Se resto da sola, come diavolo farò con la bambina e le bestie? Da un dottore, bisognava portare il Piero da un dottore, o almeno dalla stria, che alla fin fine le malattie le sapeva curare anche lei.
Grossi nuvoloni esplodevano bianchi e grigi contro il cielo azzurro, mentre la brezza inclinava gli arbusti più alti e i prati splendevano di una luce quasi metallica. Arrivarono alla radura e le vacche iniziarono pigramente a pascolare. La Tilde si mise guardare incantata il movimento lento delle loro code. Il vento le fece in venire in mente il giorno che aveva sposato il Piero. Uscita dalla chiesa, una folata le aveva scaravoltato il velo, buttandoglielo sulla faccia. Lei istintivamente aveva portato le mani alla testa per bloccarlo, e il Piero l’aveva abbracciata stretta, sotto la pioggia di riso e le campane a distesa.
Quanto di quel tempo che era passato. In viaggio di nozze erano venuti su all’alpeggio, con tutta la mandria, per incominciare la stagione. Che il Piero, quella passione lì delle bestie ce l’aveva sempre avuta, e ce l’avrebbe avuta sempre, tant’è che le vacche avevano vinto anche qualche premio, giù alla fiera d’autunno. Una felicità vera per il Piero, che il campanaccio che aveva vinto l’aveva appeso alla porta di casa, e tutte le volte che arrivava lo suonava come un bambino.
L’Angela, intanto, vagava per il prato raccogliendo fiori che poi dava da mangiare alle vacche. La loro lingua ruvida e avvolgente le faceva il solletico sulle mani e lei rideva buttando all’indietro la testa e poi scappando via, a raccogliere altri fiori.
La Tilde si alzò per richiamare una vacca che si stava allontanando un po’ troppo, poi tornò a sedersi sopra il sasso. Restarono fino a quando il sole iniziò ad abbassarsi, poi la donna radunò le vacche e iniziò a instradarle per scendere lungo il sentiero. Si mossero a passo lento fino a quando non arrivarono in vista della baita. Allora la Tilde accelerò perché voleva vedere come stava Piero. Lo trovò sul retro, intento a spaccare la legna. «Non sei stato a letto?“
«L’è mica ancora ora di mettermi via, va’.»
La Tilde si affrettò in casa, andò ad accendere la cucina economica, ci mise sopra un pentolone d’acqua mentre il Piero fece entrare le vacche nella stalla: «Angela! È ora di mungere!»
L’Angela camminò lentamente verso la stalla. Non aveva nessuna voglia di mungere. Prese il secchio di alluminio e uno straccio bagnato, si sedette su uno sgabello di legno e iniziò pigramente a maneggiare le mammelle della prima vacca. Sperava che quella sera avrebbe potuto giocare con le figurine nuove, invece niente, che alla fine non avevano mica fatto in tempo a comperarle, sempre mungere mammamia, doveva aspettare venerdì, sperando che l’Antonio gliele avrebbe portate.
__________________________________________________________________________________________________________
Il giorno dopo erano nubi grigie e acqua leggera. La Tilde si alzò presto come sempre, guardò fuori dalla finestra e pensò che le vacche potevano ben stare in stalla per una mattina, con quel tempo, e che finalmente era arrivato il momento giusto.
«Andiamo Angela!»
«E dove andiamo?»
«Vieni e basta, quante storie.»
Non sapeva che cosa avrebbe potuto trovare né che cosa avrebbe raccontato alla bambina.
Imboccò il sentiero che portava al lago. Seguì con lo sguardo una grossa marmotta correre ignara lungo il pendio davanti a lei e invidiò per un attimo il suo infilarsi in una tana nascosta. Si fermò a raccogliere dei rametti di timo bagnati e quando il sentiero iniziò a farsi più ripido sedette qualche minuto su grosso masso per far riposare l’Angela.
«Ma dove andiamo?»
«È una sorpresa sai. Nel lago di sopra… c’è un pesce con le pinne d’oro…» disse «ma si vede solo nei giorni di pioggia. E nemmeno sempre!» disse la Tilde con il tono con cui si contano le fiabe.
«Con le pinne d’oro?!» disse l’Angela incredula.
«Certo. Quel pesciolino era una principessa una volta, ma quando era molto piccola una strega cattiva la gettò nel lago, perché aveva capelli biondi, del colore dell’oro, e la strega che invece li aveva neri era molto gelosa. Allora l’angelo custode l’ha trasformata in un pesciolino con le pinne d’oro, per salvarla.»
Dagli ultimi metri di sentiero, che salivano ripidi, la conca del lago si indovinava. L’acqua era grigia e piatta. La Tilde Si avvicinò al lago a piccoli passi, come se avesse paura di svegliare qualcuno. Si sedette su un grosso masso e rimase immobile, a contemplare inutilmente il fondo. L’Angela andò invece in riva, guardando attenta le acque, per cercare di vedere il pesciolino dalle pinne d’oro.
Le nubi grigie si addossavano sulle cime che circondavano il lago. Si distingueva, in alto, il volo di un rapace. L’Angela mosse qualche passo lungo la spiaggia di ciottoli, avanti e indietro, guardando prima per terra e poi lungo la superficie dell’acqua, senza vedere nulla, se non una distesa piatta di grigio uniforme.
«Guarda mamma, c’è qualcosa lì!» disse a un certo punto puntando l’indice.
La Tilde raggiunse velocemente la bambina sul bordo del lago. In un angolo tra due grossi sassi vide un panno bianco, mezzo ricoperto di fango. Senza indugio, lo prese tra le mani, lo sciacquò e lo strizzò.
«Scaviamo una buca Angela, aiutami!» disse alla bambina mentre iniziavano a scendere le prime gocce di pioggia.
«Ma io devo vedere il pesciolino, non scavare una buca!»
La Tilde tirò fuori dalla gerla una piccola zappa e allontanatasi un po’ dalla riva iniziò velocemente a scavare. «Tira fuori la terra, Angela, dai che facciamo un bel buco.»
«Ma perché dobbiamo fare un bel buco?»
«Scava e basta.» Rispose secca.
Quando la Tilde ritenne che il buco fosse sufficientemente profondo ci adagiò il panno, ripiegandolo delicatamente in più parti. «Questo panno l’era della principessa, sai. Solo se lo seppelliamo e se diciamo una preghiera possiamo vedere il pesciolino dalle pinne d’oro.»
L’Angela aiutò la madre a chiudere la buca, ricoprendo di terra il panno.
«Vai a prendere due legnetti, svelta che piove» disse la Tilde.
L’Angela sparì nel bosco e ne riemerse quasi subito con in mano due piccoli rametti di larice. La Tilde li posò a croce sopra il piccolo scavo, lentamente, con gesti che volevano essere solenni.
«Requiemmetèrna dònas, Dómine,» disse guardando severa la bambina
«E luss perpetua luciatèis… » rispose l’Angela sottovoce.
Entrambe si fecero il segno della croce, mentre iniziava a piovere più forte. «Andiamo adesso» disse la Tilde «andiamo veloci.»
«Ma il pesciolino?»
«Il pesciolino esce solo quando c’è il sole, non lo vedremo oggi. »
«Ma prima hai detto che si vede solo quando piove!»
«Ah sì? Mi sono sbagliata allora, andiamo.»
«E torniamo a vederlo? »
«Certo che torniamo, i prossimi giorni. »
Percorsero quasi di corsa il sentiero a ritroso, stando attente a non scivolare sui sassi resi scivolosi dalla pioggia. Quando arrivarono in vista della conca dove si trovava l’alpeggio, la pioggia era talmente fitta che le baite non si distinguevano. Da quando erano uscite dal bosco, non c’era stato modo di proteggersi dall’acqua e quando arrivarono alla baita erano completamente fradice.
«Ma c’era proprio bisogno di andare su?» il Piero le accolse scotendo la testa, mentre non appena entrate, sul pavimento si creavano piccole pozzanghere.
«Non l’ho visto il pesciolino, uffa!» disse l’Angela con voce lagnosa.
«Sei tu il pesciolino, stupidotta, guarda come grondi acqua, vai a cambiarti!»
La bambina salì la scala a pioli per il sottotetto.
«E allora che cosa hai trovato?» chiese il Piero alla Tilde sottovoce una volta rimasti soli, con una piega di ironia nella voce, mentre lei si asciugava i capelli con un telo.
«Ho trovato un panno bianco» rispose lei seria «di sicuro era della bambina. L’ho seppellito, ecco cosa ho fatto. La bambina non c’è più, ma almeno una tomba, almeno.»
«Alla fine della settimana scendiamo» disse il Piero, cambiando improvvisamente discorso.
«È ben ora che andiamo giù.» Decideva sempre il Piero quando era il tempo dello scarghé, di portar giù le vacche, di chiudere la baite, di dire che l’estate l’era andata.
Tutte la volte, la Tilde accoglieva la notizia così. A tratti era felice, ma chiudere la baita era sempre un po’ anche un dispiacere. Quella sera, dopo aver rigovernato i piatti e dopo aver messo a dormire l’Angela, la Tilde e il Piero si sedettero sulla panca fuori dalla porta.
«Andiamo giù dalla strada», disse il Piero
«Dalla strada?» Rispose la Tilde
«Dalla strada», ripeté il Piero: «l’avran ben costruita per qualcosa.»
«Dovrai vedere un dottore, appena che siam giù»
“Un dottore, un dottore», disse il Piero sputando per terra. «Che cosa vuoi che mi dica un dottore.»
Ci metteva di meno a imbrunire. La Tilde si sfregò forte le braccia con le mani, che l’aria si faceva freschina. Gettò uno sguardo indietro. In direzione del lago si distinguevano mute le sagome delle montagne e le prime stelle bucavano il cielo. La Tilde rivide l’acqua grigia e il panno che aveva seppellito.
«Sembra ieri neh,» disse al Piero «che sono andati via gli Zampitelli, Por nanin. »
Nina dai capelli d’oro
Parte terza (parte seconda, parte prima)

La mattina dopo, molto presto, campanacci di vacche, scalpiccio di andirivieni, urla di bambini e rumori di vettovaglie annunciavano una partenza improvvisa. Non era ancora l’ora dello scarghé, ma gli Zampitelli se ne andavano.
La giornata si annunciava limpida e fresca, la conca era ancora insonnolita nell’ombra, umida di rugiada, qualche striatura rosa nel cielo.
La Tilde, al sentire i rumori, si era alzata in fretta dal letto e si era messa a guardare dalla finestra. Vide l’Aldina fare avanti e indietro dalla baita caricando poche cose nella gerla, i bambini più grandi erano in piedi vicino alle vacche, quelli più piccoli seduti sulla panca, che tremavano di freddo nelle braghette corte. Il Giovanni uscì dalla baita per ultimo, si caricò il gerlo pesante sulle spalle. Chiamò le due vacche e iniziò a muoversi. I bambini lentamente lo seguirono e l’Aldina, avvolta in una pesante mantella di lana, chiuse la fila. Presero il sentiero che per stretti tornanti saliva verso il passo di Cumigliano. La Tilde li guardò fino a quando le loro figure iniziarono a perdere consistenza, i loro movimenti a confondersi tra le rocce e l’erba, fino a sparire, fino a sparire proprio.
L’Aldina non le aveva detto niente il giorno prima, neanche una parola, ma magari, pensò la Tilde, magari nemmeno lei lo sapeva. Bastava che il Giovanni comandasse domani si va, e si poteva solo che mettere armi e bagagli nel carro e zitta, e partire prima che si poteva.
A un certo punto la Tilde sentì sulla spalla la mano del Piero. «Vanno in Svizzera. È meglio che non stanno più qui, con quello che è successo. Lo diceva da un po’, il Giovanni, che voleva andare in Svizzera. Anderà sotto padrone, contento lui.» Disse alzando le spalle
«Mi dispiace per l’Aldina, e per i bambini» rispose brusca la Tilde, facendo ricadere la tendina sul vetro e alzandosi per ravvivare la stufa a legna.
«E un’altra baita che si chiude” aggiunse a voce bassa, scuotendo la testa.
«Chi va in Svizzera?» chiese l’Angela che si era avvicinata silenziosamente alla madre, stropicciandosi gli occhi, ancora avvolta nella camicia da notte di flanella.
«Gli Zampitelli, partono» le disse la Tilde.
«E perché vanno via? E con chi gioco adesso io?» disse l’Angela con tono lamentoso e battendo lentamente i piedi per terra, uno dopo l’altro. «Andiamo anche noi in Svizzera, così posso giocare anche io con loro, papà, vero che andiamo anche noi in Svizzera? Io non voglio più stare qui da sola, io voglio andare in Svizzera!»
Era proprio così, con la partenza degli Zampitelli andava a finire che l’Angela rimaneva l’unica bambina su all’alpe. Col tempo, le famiglie si erano trasferite tutte in basso, nei paesi del fondovalle, paesi con le case messe in fila, strette attorno alla statale. Prima degli Zampitelli, i Tarchera e i Bartoli avevano smesso anche loro di portar le bestie ai pascoli alti. Le vacche vendute, gli alpeggi sprangati. L’Italia cambiava il passo. Quasi d’un tratto, la vita com’era diventava vecchia; prima ancora di arrivare giù, in fondovalle, prima ancora di vedere tra gli alberi la strada, dagli ultimi tornanti del sentiero sentivi i rumori delle lambrette e delle automobili, e poi , quando nel naso ti entrava l’odore acre dello scarico, se ne stava lì un pezzo, anche quando la macchina era andata via.
C’era la fabbrica. La chiamavano così, la fabbrica, uno scatolone di cemento grigio con una ciminiera alta. Produceva materie chimiche dai nomi che era impossibile ricordare, il Piero sapeva che servivano per fare la colla, il DDT e tante altre cose. La fabbrica se le era mangiate vive le persone, se la mangiava ogni mattina, quando entravano come formiche da quel cancello enorme, e le risputava fuori la sera. La fabbrica aveva sempre fame, e aveva richiamato con le sue sirene gli uomini da tutta la valle, uomini che le sirene le avevano seguite, senza preoccuparsi di farsi legare come Ulisse.
Il Guido Tarchera, presèmpio, era uno di quelli che si era fatto mangiare e all’alpeggio non l’avevano proprio più visto, mentre il Beppe Bartoli saliva solo il fine settimana, con tutta la famiglia, tant’è che il Piero ormai li chiamava “i villeggianti”. Arrivavano il venerdì, verso sera. Li precedevano le grida dei bambini, che all’inizio in città on erano mica troppo contenti: «È tutto stretto» diceva sempre l’Antonio, il più picinin. L’Angela contava i giorni e non vedeva l’ora che arrivassero, anche perché l’Antonio portava sempre qualcosa di nuovo: una volta era il pallone di cuoio, un’altra l’album delle figurine con gli animali e le regalava sempre quelle doppie. La Marta, la sorella grande dell’Antonio, non giocava più con loro, passava il tempo a sbuffare, a sedersi su una sdraio scalcagnata e a leggere i fotoromanzi. Una volta l’Angela le aveva preso il giornale e l’aveva sfogliato velocemente. C’era un ragazzo giovane, con i capelli chiari, che guidava una macchina senza il tetto. La Marta glielo aveva strappato dalle mani subito: «Che cosa guardi che sei ancora pisciasotto?» le aveva urlato, e se n’era andata con il giornale stretto al petto, stizzita, pestando i piedi.
«Non sono pisciasotto, ho dieci anni!» le rispose l’Angela «Dieci anni ti ho detto!»
Era arrivata a casa imbronciata, tant’è che la Tilde le aveva chiesto che cosa avesse mai, da tenere quella piva. «Mamma, mi compri anche a me il fotoromanzo?»
La Tilde scoppiò a ridere forte. «Ma cosa ne sai te del fotoromanzo!» le disse asciugandosi le mani nel grembiule.
«La Marta li legge e mi ha detto che sono pisciasotto!»
«La Marta è grande, quando sei grande li leggi anche tu!»
«Sempre quando sei grande però, uffa!» sbuffò la bambina.
Poi arrivava la domenica sera e allora i Bartoli ripartivano, non senza sospiri. «Ma beati voi che restate qui» diceva il Beppe ogni volta che, tornando giù, passava davanti alla baita del Piero che di rimando scoteva la testa: «E perché sei andato via? Non stai bene sottopadrone?» gli diceva mezzo ridendo e mezzo serio.
«E noi quando ce ne andiamo? Ce ne andiamo anche noi vero?» chiedeva l’Angela tutte le volte.
L’anno prossimo, magari l’anno prossimo ce ne andiamo anche noi”. Diceva la Tilde.
_________________
La Tilde insegnava all’Angela a mungere e a fare il burro con la zangola e la mandava a raccogliere i mirtilli e le bacche di ginepro. Era un’estate ballerina, una giornata lenta e piena di luce, e poi, d’un colpo il freddo, il grigio, la pioggia e l’Angela con il naso appiccicato ai vetri appannati e sgocciolanti. Ma in quei giorni di far niente o poco, l’Angela si sognava già grande, si vedeva pittare le labbra come faceva la Marta e passare le ore a leggere i fotoromanzi. Pensava che a scendere in città, avrebbe potuto tutti i giorni fare il cambio delle figurine con l’Antonio e giocare con il pallone di cuoio. Oppure guardava fissa il sentiero dove se n’erano andati gli Zampitelli e pensava che avrebbe potuto raggiungerli. Avrebbe preso la gerla, quella piccolina, ci avrebbe stipato dentro i suoi vestiti e un pezzo di formaggio, se la sarebbe messa su in spalla e via, via verso la Svizzera.
La Tilde, invece, guardava sempre verso il lago. Aveva quell’idea fissa, di andare su a cercare la bambina, che l’acqua doveva averla ben restituita. La grazia di una tomba almeno, stellina del cielo. Ma negli ultimi tempi non si poteva concedere il lusso di una passeggiata. Il Piero era un po’ che andava a dormire presto la sera, diceva che era stanco, mangiava poco e entrava nel letto che nemmeno era buio fatto. Ogni tanto chiedeva alla Tilde di portar su le bestie ai pascoli alti, che lui non si sentiva.
Scendere al paese con la bambina, per vendere i formaggi e comprare il vino e il pane, comunque, ci voleva andare lui. Camminavano fianco a fianco e il Piero regolava il suo passo su quello piccolo dell’Angela, tenendola per mano. Vestiva i pantaloni di velluto a coste, con un paio di bretelle nere sopra una maglietta bianca di bucato. La sua mano era ruvida e nera e i suoi piedi si divertivano a calciare sassi lungo il sentiero, che schizzavano di lato o scivolavano sull’erba pochi metri più in là. Avrebbe potuto scendere dalla strada nuova in costruzione, ma in fondo era abituato a usare il sentiero, conosceva ogni tornante, era sempre salito e sceso di lì. La strada poi, adesso che tutti scendevano l’avevano costruita la strada, vai a capire.
Per un po’ aveva fatto loro compagnia solo il fruscio del velluto e il rumore delle suole sul sentiero, poi Piero si era inventato qualcosa da dire, che quando finivano da soli non sapeva mai come far passare il tempo. «Li vedi quei sassoni lì?» le diceva indicando i grossi massi erratici che spuntavano dall’erba, neri come dorsi di balene.
«Lo vedi la roccia com’è liscia? Una volta c’era il ghiaccio sopra, il ghiaccio, che è venuto avanti e ha trascinato giù i massi». Ma all’Angela, la storia del ghiaccio non interessava né punto né poco.
«Andiamo a trovare l’Antonio?»
«Non facciamo in tempo Angela, dobbiamo andare al negozio e poi ritornare. Porta pioggia oggi il cielo»
«E allora mi compri le figurine?»
Il Piero sospirò: «Vediamo Angela, vediamo.»
«E perché vediamo?»
E come il Piero aveva previsto, un violento acquazzone li sorprese all’ingresso del villaggio obbligandoli ad affrettare il passo e a entrare nel negozio di corsa, trafelati.
«Denter, denter!» Li accolse Marianna, la bottegaia, che ogni volta teneva da parte qualche dolcetto per l’Angela. «L’è matt, l’è matt!» disse guardando verso il cielo e scuotendo la testa.
Entrarono mentre la radio trasmetteva le note de “Una lacrima sul viso”, una canzone che era tutta l’estate che la si sentiva.
«Hai visto Piero?» disse la Marianna «me l’ha portata mio figlio, l’è un “transistor»
La Marianna prese la piccola radio laccata rossa e la porse al Piero: «Lo vedi bene com’è piccola, sta anche in tasca.»
Il Piero la prese tra le mani: «L’è bella, e porta via poco posto. Andrebbe bene anche a me su all’alpe.»
«Il mio Giovanni dice che adesso le fanno tutte così» disse la Marianna.
«Bene si sente bene» disse il Piero giocando con il volume. «Di’ al tò bocia di portarmene una. Terrà ben compagnia alla Tilde.»
«Ma sicuro!» disse entusiasta la Marianna «E se passi dal circolo, vedrai anche che hanno preso la televisione. Che alla sera, quando c’è la partita o il Musichiere, sai quanta gente che arriva a guardarla, e tutti col vestito buono, sembra sempre festa!»
Piero sistemò nello zaino i formaggi e il vino, mise un braccio fuori dalla porta per capire se stesse spiovendo e poi prese per mano l’Angela. «Arrivederci Marianna, che tra poco dall’Alpe veniamo giù.»
«Vi aspetto ben! E salutatemi la Tilde, che ho voglia di vederla!»
“Passiamo al Circolo, Angela. Così vedi la televisione.”
“Ma io voglio le figurine, non la televisione, andiamo dall’Antonio!”
“Non facciamo in tempo Angela, è bella la televisione, non vuoi vederla?”
Il tempo di fare pochi passi e al circolo erano già arrivati, che al paese, alla fine, con pochi passi arrivai dappertutto. Entrarono nella stanza, avvoltolata nella penombra, mentre alcuni uomini erano seduti al tavolo intenti a dividersi un mezzo litro di vino.
«Oh il Piero!» disse uno di loro, alzandosi rumorosamente dalla sedia e andando a stringergli la mano. «C’è qui giusto un bicchiere per te, noi non ti aspettavamo, ma lui sì!» Tutti scoppiarono a ridere e fecero largo al Piero che si sedette prendendosi in braccio l’Angela. «Eh te sei ancora piccola per il vino! Lo vuoi un bel gelato? Oste, porta un bel gelato con lo stecco per la fiolina!» disse uno degli uomini spettinandole in capelli.
«Dov’è la televisione?» chiese l’Angela all’oste che stava riempiendo una nuova caraffa di vino.
«Vieni, vieni»: l’oste la fece scendere dalle ginocchia del Piero e le indicò un grosso scatolone con davanti uno schermo di vetro. «Adesso però mi sa che i programmi non ci sono.» L’uomo accese l’apparecchio e, dopo qualche minuto, sullo schermo si materializzarono lentamente delle immagini: nuvole che scorrevano dal basso verso l’alto con degli strani ghirighori e una musica mai sentita prima.
L’Angela guardò fissa lo schermo per qualche minuto: «Nuvole, nuvole, ce ne sono tante anche su all’alpe, ma qui è tutto uguale, non mi piace la televisione!»
L’oste rise: «La vedrai un’altra volta Angela, quando ci sono i programmi!»
“Ma che cos’è questo?” chiese la bambina puntando il dito verso il juke box.
“Questo qui è la macchina della musica” rispose l’oste. “Dai, scegli un disco!”
L’Angela indicò un nome a caso e l’oste inserì la moneta. Il braccio meccanico prelevò il disco in vinile e preceduta da un breve fruscio iniziò la canzone e la bambina batté le mani contenta.
“Ancora un bicchiere dai, prima che vai via!” disse al Piero uno degli uomini
“No no, adesso saliamo, che è lunga con la bambina” rispose il Piero.
“E dobbiamo comprare le figurine!” disse l’Angela!
Lentamente si misero in cammino per riprendere il sentiero. Era l’ora più calda del giorno, lo scroscio d’acqua era passato e aveva lasciato l’aria umida e calda così, una volta entrati nel bosco, fu un sollievo sentire la frescura dell’ombra dei castagni secolari. Tafani, cavallette, formiche indaffarate, in lontananza il rumore di un picchio: il bosco era in fermento come si addice alla piena estate, eppure quel caldo, quel verde pieno, aveva già in sé un che di malinconico, la sfacciataggine di luglio era lontana, nell’aria una voglia di resa, un sentore d’autunno. Anche il Piero ogni tanto si fermava a prendere fiato: «Aspettami Angela!” le diceva ridendo, “che sono vecchio e stanco!»
Arrivarono alla baita le prime ore del pomeriggio. La Tilde era al lavatoio a sfregare i panni, con le braccia arrossate dall’acqua gelida, che cantava una vecchia canzone.
«Tilde, l’anno prossimo ti portiamo su il transistor» disse il Piero appena entrato nella baita «che l’è piccolo e pesa poco, così vi fa compagnia a te e all’Angela.»
«Il transistor?» rispose la Tilde con le mani sui fianchi.
«È una radio piccola, leggera e che si sente benissimo, il figlio della Marianna me ne porta uno, tutti i canali prende.»
«Sono stracca Piero, forse l’anno prossimo è anche per noi l’ora di cambiare vita.»
«È qui la vita, dove vuoi andare? Io non voglio andare in fabbrica, io voglio stare qui. Qui è bello, in fabbrica mica si respira.»
«E l’Angela?» ribatteva Tilde «Soffre a stare qui, l’è rimasta sola»
«L’Angela fa quello che dico io, quante storie.»
—————–
Nina dai capelli d’oro
Parte seconda (prima parte)

Ovvio che non aveva detto niente all’Aldina, che le donne poi fanno un sacco di storie per ogni cosa. Ma l’Aldina non era mica stupida, aveva capito tutto quella lì, e infatti il Giovanni a un bel momento se la trovò sul sentiero, se la vide proprio davanti che saliva di furia, con ancora su il camicione da notte e coi capelli sciolti, come una strega o un fantasma.
Non appena lo vide, gli si scagliò contro, che lui dovette tenerla per le braccia mentre lei scalciava, si contorceva e gridava, che aveva il demonio in corpo. «Spero che muori disgraziato, spero che muori!» gli urlava contro al Giovanni, e cercava di sputargli in faccia, tanto che alla fine lui per liberarsi la buttò per terra strattonandola.
«’Dèss basta!» le urlò addosso come un tuono. «Che lo sapevi anche tu che non potevamo tenerla!» E se ne andò sbuffando e lasciandola lì per terra, tra i sassi e il fango, con il passo pesante di chi ha appena fatto una fatica, una delle tante, che la giornata non è mica finita e c’è ben ancora da far cose.
___________
Ore dopo, fu la Tilde a ritrovare l’Aldina e a riportarla a casa – che era un pezzo che mancava dall’alpeggio. La Tilde aveva capito subito che cosa era successo e l’era salita su di corsa. Il sentiero saliva all’inizio non tanto ripido, attraverso i pascoli, poi diventava più dritto, che le ginocchia fin quasi alla bocca te le portavi, ed entrava in un bosco di larici via via più radi e alla fine, dopo qualche tornante e un traverso stretto e messo di sguincio, la conca del lago la potevi ben intuire, dovevi solo continuare a salire, fino a dove spianava.
La Tilde vide così l’Aldina in piedi a bordo del lago, con i lunghi capelli neri abbandonati lungo le spalle, che era la prima volta che la vedeva così. Se ne stava lì, come di sale, in mezzo al vento frizzante che d’un tratto si era sollevato, e alle prime gocce di pioggia che puntinavano il lago.
I pochi larici attorno allo specchio d’acqua erano neri e muti. I grandi massi disseminati nell’ampia conca sembravano aver perso di consistenza e confondersi nella luce ovattata. La Tilde si avvicinò lentamente all’Aldina e la prese per le spalle.
«Numa a cà adèss» le disse sottovoce.
L’Aldina rimase immobile.
«Andiamo» le ripeté con voce più decisa «Ti prendi freddo e a casa ti cercano».
Si avviarono lentamente lungo il sentiero. Camminavano strette a braccetto, le labbra serrate, il respiro accelerato, anche in discesa. La pioggia in breve si era infittita e a ogni loro passo, l’erba, che il verde già cedeva al giallo, trasudava acqua.
Arrivarono presto alle baite e Tilde l’accompagnò fin sulla porta.
«Se moriva di fame era peggio, ecco cosa ha detto quel disgrasià», disse l’Aldina.
«È mai morto nessuno di fame qui.» Le rispose la Tilde ricacciando le lacrime.
Arrivato il momento di separarsi, le due donne si guardarono dritte negli occhi per qualche secondo. La Tilde andò spedita verso la sua baita, mentre l’Aldina stette per un po’ ferma sulla soglia, raccolse i capelli, prese fiato, lasciò ricadere le spalle e si decise ad aprire la porta.
«Lo sai cosa ha fatto il Giovanni?» Disse la Tilde al Piero, e ancora un po’ quasi piangeva. Non gli diede nemmeno tempo di rispondere. «Nel lago, ha preso la fiolina e l’ha buttata nel lago! Quel disgraziato, quel senzadio!» Il Piero stava mettendo legna nella cucina economica, e la guardò scuotendo la testa.
«Ti dico che ha passato la misura quello lì» disse la donna.
«Stai zitta» le disse il Piero con voce piatta.
«Che non la può mica far franca sempre…» la Tilde non finì nemmeno la frase che già piangeva, con la mascella sotto che tremava e il singhiozzo che la scuoteva tutta.
«Smettila» le disse il Piero alzando la voce, «Sai cosa succede se il Giovanni va in gattabuia? Chi è che lavora più? Sai che fine fanno i bambini? Sai che glieli portano via all’Aldina?»
«Parla piano!» Gli disse la Tilde anche lei a voce troppo alta. «Non voglio che l’Angela ti sente».
«Metti su l’acqua» le rispose il Piero «tra tutto si è fatto tardi.»
Nina dai capelli d’oro
Non scrivo qui sopra da talmente tanto, che quasi ormai non lo so più usare WordPress. Comunque, nell’ultimo anno e mezzo, ho scritto un solo racconto: “Nina dai capelli d’oro”. Siccome è lungo, anzi per i miei standard lunghissimo, lo pubblico a puntate.
 _________________________________________________________
_________________________________________________________
prima parte
Estate 1964
I giorni d’estate, all’alpeggio, erano fatti di sveglie all’alba, di vacche brunealpine o rossepezzate da mungere, di pascoli grassi sospesi da arrivarci in salita, e botton d’oro e semprevivo montano e viola di genziane, di tanti piccoli e grandi lavori da fare tutti i giorni, tutti i giorni che Dio mandava in terra, col sole o con la pioggia, che vita.
Per tanti anni le famiglie avevano portato le bestie su all’alpe. Una radura che dal paese nemmeno sospettavi che esistesse; grumi grigi di massi erratici e baite di pietra. Prati e pascoli, che salendo di quota diventavano più magri e impervi, buoni per i balzi delle capre. Era quella l’estate. Famiglie numerose, che lavoravano duro, che anche per i più piccolini prima di sera non era mai finita. Poi, quando il sole si nascondeva dietro le guglie affilate del pizzo di Trasca, quando anche l’ultima vacca era munta, c’era ancora un po’ di tempo per giocare: che erano stanchi sì i bocia, ma mai abbastanza per non avere voglia di divertirsi almeno un po’.
La famiglia di Tilde erano solo lei, Piero e l’Angela, la bambina. Ci avevano provato a darle fratellini all’Angela, a cercare almeno il maschio, ma niente, la bambina era rimasta figlia unica.
Per un po’ la Tilde ci aveva sofferto, che tutti su all’alpe avevano tanti figli e lei invece solo uno. Ma poi, che cosa vuoi fare, era andata in processione tante di quelle volte, era stata al pellegrinaggio della Madonna delle Rocce, una fatica, in ginocchio sui gradini e ogni gradino un’ave Maria graziaplèna, e niente. In preda alla disperazione era andata anche dalla Vegia di Rust, una stria, una che sapeva la fisica, che faceva miracoli con le erbe. Di nascosto da tutti era andata dalla stria, che se il Piero lo veniva a sapere poi, sai quante gliene diceva. Aveva bevuto gli infusi, le tisane, una roba amara ‘me ’l tosic, ma niente sai, era stato proprio tutto inutile e bon, alla fine la Tilde si era rassegnata, che ormai era da scemi anche solo a pensarci.
Delle volte succedeva che la Tilde sgridava l’Angela per niente, perché non si teneva i capelli in ordine, perché quando lavava i piatti bagnava dappertutto, perché non era capace di portare su le vacche ai pascoli alti da sola. Poi finiva che se l’abbracciava stretta e la mandava via stampandole due bei baci sulle guance e la guardava correre fuori, e scuoteva la testa, che proprio non capiva perché a lei era capitata una figlia sola, e per di più femmina. Che la vita è dura, ma se sei donna, qui, è dura due volte, che la testa devi tenerla ben bassa e il tuo parlare sia solo sì, sì, altro che storie, che il no è roba solo degli uomini. Uomini, poi, bisognava ben aver fortuna anche con quelli, che il Piero ancora era timorato di Dio ma ce n’erano altri che invece…
Gli Zampitelli, presèmpio, avevano nove figli e due sole vacche. Non c’era mica sempre il cibo per tutti. Delle volte la polenta arrivava dritta nelle ciotole senza companatico, altre andava meglio e ci si metteva dentro il dente di leone, raccolto nei prati, con un po’ di latte.
Ogni tanto la Tilde ne portava a casa quattro o cinque di quei bambini lì, che per l’Angela era una festa e anche per la Tilde, che le sembrava di avere una famiglia più grande. Il Piero delle volte sbuffava: «Ohè ricordati che non siamo mica poi la banca d’Italia eh, che si sa come vanno le cose.» Ma poi era contento anche lui di avere un po’ di allegria e di chiasso per casa, e i bambini li mandava sempre via con la pancia ben piena, e andava a finire che diceva sempre: «Ma poi insomma, dovranno ben mangiare tutti».
Al capofamiglia degli Zampitelli, il Giovanni, però, in qualche modo il vino non mancava mai e delle volte gli volava via anche qualche scapaccione di troppo, tant’è che’Aldina, sua moglie, ogni tanto arrivava che aveva un occhio pesto. Il Giovanni i bambini non li guardava né punto né poco, alla mattina gli diceva i lavori che dovevano fare e tanto bastava. Mai una parola, mai una carezza. Alla sera si sedeva sulla panca di fuori, con i capelli scarmigliati, i gomiti sulle cosce e tra le mani la solita bottiglia.
Quando l’Aldina restò incinta del decimo figlio, poi, lui non ci pensò mica due volte: «E come faccio a dargli da mangiare anche a questo?» Era nata poi femmina, per sua disgrazia, che il Giovanni appena l’aveva vista aveva scosso la testa e sputato per terra, è abbastanza così, non mi serve a niente aveva detto, e il suo destino l’aveva deciso bell’e che subito. E fu così che pochi giorni dopo il parto – l’Aldina voleva chiamarla Nina, ma nessuno le lasciò il tempo di battezzarla – una mattina che era ancora buio pesto, senza dir niente a nessuno, lui si fasciò la bambina addosso e salì al lago. Salì a testa bassa che macinava il sentiero veloce, fermandosi solo ogni tanto per vedere che non ci fosse in giro nessuno. Una volta arrivato, si slegò il fagotto di dosso e lo lanciò da un grosso sasso dove l’acqua era profonda. L’acqua si squarciò in larghi cerchi, inghiottì il fagotto con un rumore sordo e presto si richiuse, con un gorgoglio indifferente. Neanche un grido fece in tempo a fare la piccinina. Lui restò lì, fermo sul sasso per pochi secondi. Morire di fame era peggio, cosa credi, si disse a mezza voce. E con lo stesso passo furibondo con cui era salito scese, che intanto il cielo scuriva e l’acqua del lago da verde scuro si faceva grigia, come il manto di un topo. (continua)
Il rifugio

“E quando il dolore vi sembrerà troppo forte dovete pensare a un luogo dove rifugiarvi, un luogo che amate molto, che vi faccia sentire bene, che vi faccia sentire al sicuro. Quindi pensate adesso a quale possa essere quel luogo, perché dopo sarà tardi”.
A mia cugina B. avevano detto più o meno così al corso preparto. E lei aveva pensato alla Val Lasties, e al prato delle stelle alpine. Nel momento del dolore, si sarebbe rifugiata lì.
La Val Lasties, nelle dolomiti di Fassa, sale dal pian degli Schiavaneis fino alla forcella dei Camosci. E’ una specie di canyon, tra le enormi pareti del Piz Ciavàzes e del Sass Pordoi, sorvegliata dalla portentosa torre del Siella. Ci andai per la prima volta nel 1993, erano i primi anni che andavo in montagna e fu anche l’ultima vacanza che io e i miei cugini facemmo tutti insieme. Furono giorni magici, spensierati, innocenti e benedetti dal sole: ci lanciavamo in grandi dislivelli con poca attrezzatura e niente allenamento, non sapevamo cosa fossero gradi, spit o ramponi. Arrivare in vetta, a un rifugio o a un passo era la stessa cosa, l’incanto era il medesimo, bastava la magia di esserci, tra quelle rocce, a respirare quell’aria e riempirsi gli occhi di quelle pareti, di quegli alberi di quei fiori e niente altro.
La gita alla Val Lasties l’avevo proposta io dopo aver letto questa medesima descrizione che ho casualmente ritrovato in rete. Ricordo perfettamente come mi risuonarono queste parole “tutti lo sanno, pochi ci vanno. Perché? Non si sa”. E andiamoci allora! Avevo rotto le scatole mica poco. Lo ricordo bene. La sera prima aveva fatto temporale e la mattina non era ancora perfettamente limpido. Le pareti si sfumavano perse tra le nubi, brividi di umidità e qualche vaga puntura d’inquietudine. “La Valle delle streghe a qualsiasi costo” aveva detto R. prendendomi un po’ in giro, ed eravamo partiti. Lui si era portato anche delle corde, non so se per salire alla cima o se per il tratto attrezzato che poi ci guardammo bene dal fare.
Salimmo fino al rifugio tra nubi di condensa, pareti nere e tentativi di raggi di sole subito ricacciati. Ci pensarono le stelle alpine sui radi prati ad addolcire il nostro incedere. Poi l’altopiano del Siella, un deserto di pietra e uno sguardo giù, verso le quinte della Val de Mezdì, che mi faceva paura anche solo affacciarmi. Alla fine, solo alla fine, la sagoma del rifugio, una forma familiare, un profumo da che fame, un chissenefrega della cima, che tra poco piove, un piatto di canederli fumanti.
Tu avevi questo rito, che una volta arrivato dovevi cambiare la maglietta. Io sostenevo che era meglio farsela asciugare addosso, ma la verità è che le magliette di cambio continuo a dimenticarle, anche adesso. Avevi borbottato un po’ per le nubi, per il tempo, ma eri fatto così, borbottavi sempre per qualcosa, di sicuro però il posto ti piaceva.
Era freddo fuori, ma il calore del rifugio e il sapore dei canederli era tutto quello di cui avevamo bisogno. Felici, lo eravamo già. Tutta quella vacanza, fatta di piccole cose e di grandi risate fu indimenticabile, ma quel giorno lì credo (e spero) sia stato magico per ciascuno di noi. Per me è stata l’escursione che mi ha fatto amare la montagna, in maniera totale e definitiva. Non ci fu grande fatica, non ci furono difficoltà, solo meraviglia, stupore, appartenenza. Solo noi, tutti insieme. Spero che la Val Lasties sia stata magica anche per te. Ci siamo tornati più volte, anche insieme, su quelle montagne, ma è stato inevitabilmente diverso, non meno bello, solo diverso.
Anche oggi il dolore sembra troppo forte. Anche oggi la Val Lasties è il nostro rifugio. So che ci aspetti lì, in cima, con una maglietta di cambio pronta per ognuno di noi.
Stelle alpine d’inverno

Non amo fare bilanci di fine anno. Soprattutto, non sono in grado di farne perché dimentico tutto, a partire dagli obiettivi che mi ero data. E infatti, a scanso di equivoci, il post lo scrivo oggi che è già l’anno nuovo.
Anni fa mi feci fare un tatuaggio sulla caviglia. Con un incredibile guizzo di fantasia, scelsi il disegno di una stella alpina, senza nemmeno pensarci troppo. Nel linguaggio dei fiori – e questo credo di averlo imparato da piccola guardando “Lulù l’angelo dei fiori” – la stella alpina è il simbolo del coraggio. Credo che il mio volesse essere un tatuaggio aspirazionale, perché non posso dire che la mia vita sia costellata da atti di coraggio, tutt’altro. Poi però arrivano momenti in cui si deve almeno provare a essere all’altezza dei propri tatuaggi sogni. È tutto quello che mi e vi auguro per i prossimi 365 giorni (non ringraziatemi, sarà dura).
Quasi un elogio della velocità
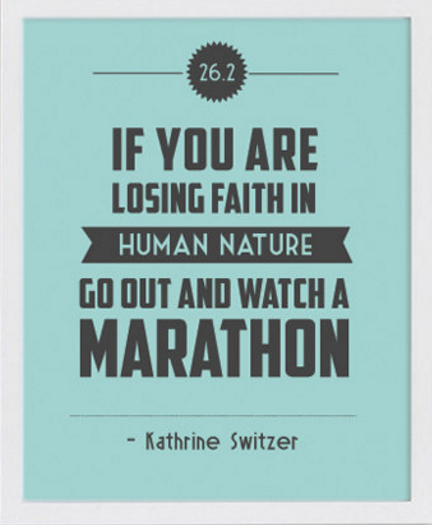
Prodromo
“Mamma, mi sono iscritta alla maratona”
“Se hai fatto una cosa del genere io non ti parlo più. Mica voglio una figlia morta.”
Al trentaseiesimo chilometro sono effettivamente stanca. O forse ho solo paura di esserlo? Sicuramente le gambe sono un po’ rigide, ma mi sono trovata in situazioni peggiori. Per distrarmi dal GPS alzo il volume delle cuffie e inizio a canticchiare. La cosa più stupida del mondo, probabilmente, perché potrei semplicemente usare meglio il mio fiato e le mie energie, ma è quello che mi va di fare in questo momento e, in fondo, voglio solo divertirmi.
Piuttosto, com’è che in un piovoso 6 novembre qualsiasi io, che ho sempre detestato la corsa, mi trovo catapultata negli ultimi chilometri di una maratona?
Tutta colpa dello scialpinismo. Quando iniziai, pensavo di essere discretamente in forma, ma ogni volta che arrivavo in cima ero esaurita, avevo dato tutto – la gente si impietosiva e mi toglieva le pelli dagli sci mentre io prendevo fiato – e a quel punto, in discesa, mi riducevo a fare quello che gli americani chiamano survival-skiing, e che io ho sempre chiamato “portare a casa le gambe”. Non un grande divertimento, in effetti.
Così decisi di corricchiare la mattina al parco, senza nessuna pretesa. Una boccata di ossigeno prima di andare al lavoro, tra i campi e le rogge, mi metteva quasi di buon umore. Pochi mesi dopo incontrai il gruppo degli Adidas Runner a Milano, e con loro iniziai degli allenamenti più strutturati. Nacquero amicizie, progetti e piccole ambizioni. Nacque, soprattutto, la passione per la corsa e di questo ancora quasi non mi capacito. Dieci chilometri, poi quindici, ma a quel punto non vuoi farla una mezza maratona? E non poca sofferenza in tutto questo. Le ripetute sui trecento metri, che mi sembravano infinite, per non parlare, molto dopo, di quelle da mille. Con il buio, con la pioggia, con il freddo e con il caldo. Ma uscendo dall’ufficio non mi sono mai detta: “ma no, stasera vado a casa”, mai. Di quale demone sono preda? (Read More)
Di picca e di penna

Riflessioni su montagna e scrittura
Quando ho iniziato a scrivere questo blog non avevo le idee chiare su quale taglio volessi dargli. Non volevo limitarmi a una mera raccolta di relazioni – o forse lo volevo, ma non avevo e non ho la precisione e la costanza necessaria – ma faticavo a trovare un tono personale, faticavo e ancora spesso fatico a trovare la mia voce.
Credo che scrivere di montagna sia una delle cose più difficili da fare. È come camminare su una cresta sottile: da una parte il baratro della retorica, dall’altra quello dei luoghi comuni (quanto fa rabbrividire la locuzione “panorama mozzafiato”? Solo per limitarmi alla più abusata). Paradossale, se si pensa a quanto siano extra-ordinari i luoghi in cui ci avventuriamo ma tant’è, non solo chi va per mare trova sirene a cui opporre il proprio fermo diniego.
Tempo fa frequentai un corso di teatro. L’insegnante ci chiese un esercizio apparentemente molto semplice: interpretare, attraverso la sola gestualità del corpo, un aggettivo da lei scelto. A un certo punto l’aggettivo fu “grande” e noi iniziammo a muoverci per l’aula mimando enormi rettangoli con la braccia, fingendo il sollevamento di carichi sovradimensionati, misurando il pavimento a passi troppo lunghi. A un certo punto, probabilmente stanca di questo spettacolo poco edificante, ci fermò: “Guardate che potrebbe anche essere solo così!” Piedi uniti, braccia lungo i fianchi, testa bassa che si solleva lentamente, occhi e bocca che si spalancano in una “O” muta.
Ecco, credo che scrivere bene di montagna richieda in qualche modo la fatica di restituire al lettore la grandezza rinunciando alle lusinghe della grandiosità, rinunciando alla grandeur, come direbbero i francesi. Un compito improbo e infinito, nel quale ciascuno deve avventurarsi da solo e trovare la propria via. Ma ci sono almeno due persone che possono guidarci su questo cammino accidentato. Due persone apparentemente lontanissime tra loro – una scrisse poco e scalò molto, l’altra scrisse moltissimo ma non credo sia mai andata per terre alte – ma che in qualche modo, per strade molto diverse, arrivano incredibilmente (?) a una conclusione molto simile.
Il mio articolo finisce qui perché, quando si passa la parola ai giganti, si può solo stare fermi a piedi uniti, braccia lungo i fianchi, testa bassa che lentamente si solleva, occhi e bocca spalancati in una “O” muta.
“Raccontare, parlare, è molto difficile. È sempre duro arrivare così vicino all’essenza della vita e poi, dopo, ritornare indietro e sentirsi imprigionati nelle strettoie del linguaggio, completamente inadeguato a tradurre in simboli i concetti e la totalità dell’esperienza vissuta. Un’esperienza lunga e sofferta che mi ha permesso di capire una verità fondamentale: alla base di tutto, di ogni azione che l’uomo compie, deve esserci sempre l’Amore.” Renato Casarotto
“Ho scoperto che la disciplina più difficile nella scrittura è cercare di partecipare al gioco senza lasciarsi sopraffare dall’insicurezza, dalla vanità e dall’egocentrismo. Mostrare al lettore che si è brillanti, spiritosi, pieni di talento e così via, cercare di piacere, sono cose che, anche lasciando da parte la questione dell’onestà, non hanno abbastanza calorie motivazionali per sostenere uno scrittore molto a lungo. Devi disciplinarti e imparare a dar voce solo alla parte di te che ama le cose che scrivi, che ama il testo a cui stai lavorando. Che ama e basta, forse. Il talento è solo uno strumento. È come avere una penna che scrive invece di una che non scrive. Non sto dicendo che riesco costantemente a rimanere fedele a questi principi quando scrivo, ma mi sembra che la grossa distinzione fra grande arte e arte mediocre si nasconda nello scopo da cui è mosso il cuore di quell’arte, nei fini che si è proposta la coscienza che sta dietro il testo. Ha qualcosa a che fare con l’amore. Con la disciplina che ti permette di far parlare la parte di te che ama, invece che quella che vuole soltanto essere amata.” David Foster Wallace
 gennaio 10, 2019
gennaio 10, 2019 